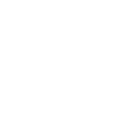Dialogo con Annamaria Palmieri su Pier Paolo Pasolini
da Una Rosa nel cuore. 7.5 Il maestro (pagg. 155-159)
Annamaria Palmieri ha curato con Antonella Tredicine Per una pedagogia emancipante – Pasolini con rustic amòur, pubblicato nel 2022 da Guida Editori, il trasferimento su carta del Convegno Nazionale di Studi “Pasolini e la Pedagogia” di qualche anno fa. Ho provato a “interrogarla”.
Cara Annamaria, nella narrazione spesso distorta degli “anni di piombo”, ricorre il riferimento ai “cattivi maestri”. Una sorta di “pedagogia del male” che avrebbe condizionato e strumentalizzato un’intera generazione. Questa interpretazione mi è sempre apparsa riduttiva e per certi versi autoconsolatoria. Ricorda i genitori che giustificano i comportamenti dei propri figli attribuendo tutte le colpe alle “cattive compagnie”. Inoltre, rappresenta un’idea verticale, dall’alto verso il basso, dell’approccio pedagogico che Pasolini, il maestro Pasolini, aveva profondamente contestato. Non da meno, la funzione pedagogica dei “maestri” risulta decisiva nel processo di crescita delle nuove generazioni. A Pasolini si attribuisce un eccesso di severità, un atteggiamento duro e critico verso i giovani e, inevitabilmente, il ricordo torna ai versi su Valle Giulia.

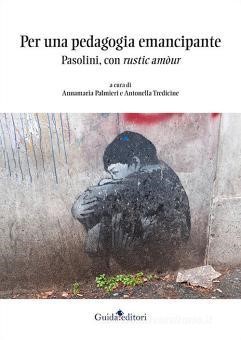

Ho ricavato la risposta di Annamaria direttamente dal saggio a sua firma, Oltre la pandemia, i giovani, la scuola, la politica… l’insegnamento di Pasolini, tratto dal libro Per una pedagogia emancipante. "Ci chiediamo spesso cosa direbbe Pier Paolo Pasolini oggi (o cosa avrebbe detto nel 1977). Benché abituati alle sue provocazioni nessuno di noi può dire di sapere cosa direbbe del modo in cui il mondo reagisce ai nuovi assetti geopolitici o, ancora, cosa direbbe ai giovani sulla rete, sulla transizione ecologica, sul modo in cui hanno saputo o anche solo pensato e potuto reagire alla crisi delle ideologie, ai venti di guerra che attraversano il mondo, alle migrazioni, alle fluidità che caratterizzano gli scenari della formazione e del lavoro, presente o futuro. Maturazione antropologica e genocidio culturale sono la cornice storico-sociale al cui interno, in particolare nell’ultimo decennio della sua vita, Pasolini collocò la crisi dell’insegnamento. Senza per questo smettere mai, nell’impossibilità di educare i giovani a uscire dalla mortificazione omologante del capitalismo, di portare comunque la propria testimonianza. Quello che un maestro deve sempre essere in grado di fare: testimoniare la propria esistenza per mettere in moto il ‘dubbio’, come scriverà al suo alunno inventato, il napoletano Gennariello. L’esaurimento del discorso pedagogico che Pasolini denunciava, in relazione al ‘nuovo fascismo’, come egli lo definì, ci apre però un’altra strada, una nuova pedagogia. Politica. Nella pedagogia pasoliniana lo spazio scolastico è un’avventura dell’ascolto e di sguardi che cominciano a dialogare: essa rappresenta la possibilità di dare spazio alla vita, in cui le differenze siano legittime e vitali.” Quindi, nessun intento censorio (e come avrebbe potuto, proprio lui, che della censura fu vittima per tutto il tempo della propria vita) o anche solo di giudizio imposto in maniera unilaterale e, pertanto, di per sé violenta. Probabilmente, Pasolini avrebbe rivolto a quei giovani “persi” l’invito di Antonio Gramsci del quale si era nutrito da giovane: “Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra forza”. Quella spinta che lo portò a incontrare, nel 1940, Roberto Longhi presso la facoltà di Lettere di Bologna e del quale scrisse: “Che cos’è un maestro? Egli viene vissuto e la coscienza del suo valore è essenziale. […] L’aula dove insegnava era un posto diverso da tutti gli altri, fuori dall’entropia scolastica.
Longhi era sguainato come una spada. Parlava come nessuno parlava. Il suo silenzio era una completa novità. La sua ironia non aveva precedenti. La sua curiosità non aveva modelli. La sua eloquenza non aveva motivazioni. Per un ragazzo oppresso, umiliato dalla cultura scolastica, dal conformismo della società fascista, questa era la rivoluzione”. Ecco come, a proposito di rivoluzione e di rivoluzionari, di cattivi maestri e di pedagogia emancipante, pur avendo intrapreso in origine strade così diverse, con Annamaria sia stato possibile incontrarsi e riuscire a percorrere un importante tratto di strada, per me l’ultimo dal punto di vista professionale, in difesa della scuola pubblica, del valore dell’istruzione e della possibilità di continuare a rendere accessibile e utilizzabile, per tutte e tutti, il maggior numero di parole possibile.
Ma la poesia di Pier Paolo Pasolini su Valle Giulia, che tanti hanno citato a sproposito per adattarla alla propria, miserabile, esigenza contingente, è mai stata letta fino in fondo? Viene perfino pubblicata in versione ridotta, quasi censurata. Mi riporta a Rosa Luxemburg che, dopo aver tanto battagliato con i propri compagni ed essersi dichiarata contraria all’insurrezione della “rivolta di gennaio”, morì con loro sulle barricate.
«È così, caro Giovanni – commenta Annamaria, a cui ho sottoposto queste pagine. In realtà Pasolini, amava moltissimo i giovani, e negli anni Sessanta, ancor prima di Valle Giulia, rispondeva alle loro domande e istanze in modo ben diverso da quello che rinvieni in quei versi di “odio” liberato dall’amore. In una lettera su Vie Nuove, rivista legata al Pci per cui tenne una rubrica tra il 1960 e il 1965, Pasolini scrisse qualcosa che ti fa capire bene quante aspettative nutrisse nei loro riguardi: “Voi giovani avete un unico dovere: quello di razionalizzare il senso di imbecillità che vi danno i grandi, con le loro solenni ipocrisie, le loro decrepite e faziose istituzioni”. Ma l’innamorato dei ragazzi sa poi schierarsi contro i ragazzi, quando li vede invecchiare come gli adulti che da sempre giudica imbecilli. E non li perdona, non perdona loro di non avere più una “loro lingua” veramente rivoluzionaria, intrappolati come sono nei simboli e nella richiesta del potere, che genera violenza. Quel potere e quella violenza a cui invece, da veri rivoluzionari, avrebbero dovuto voler rinunciare: perché nessun giovane, tanto meno questi “giovani infelici” così uguali ai loro padri, con una lingua “vecchia” può descrivere e cambiare il mondo in modo nuovo. Pasolini se ne andrà in Africa e in India a cercare quella verginità rivoluzionaria che, ai suoi occhi, i giovani occidentali degli anni Sessanta e Settanta avevano perso. E la sua atroce morte gli ha risparmiato il resto…».